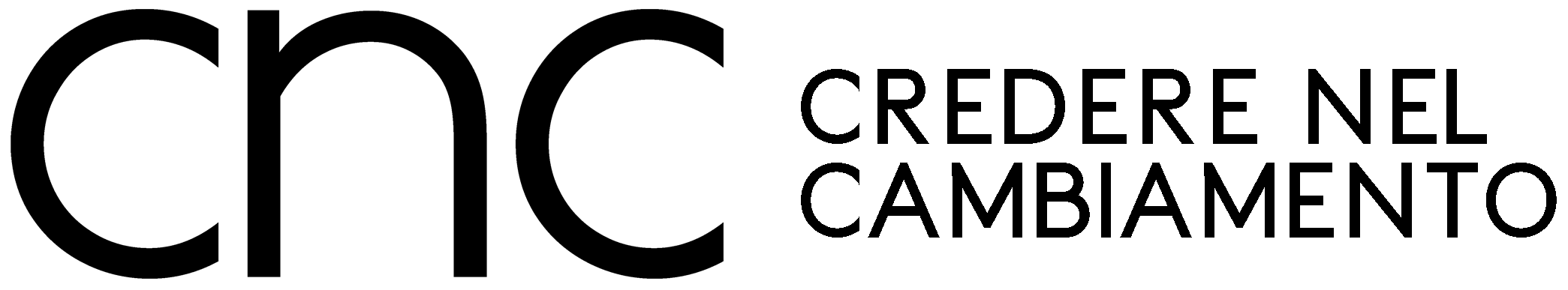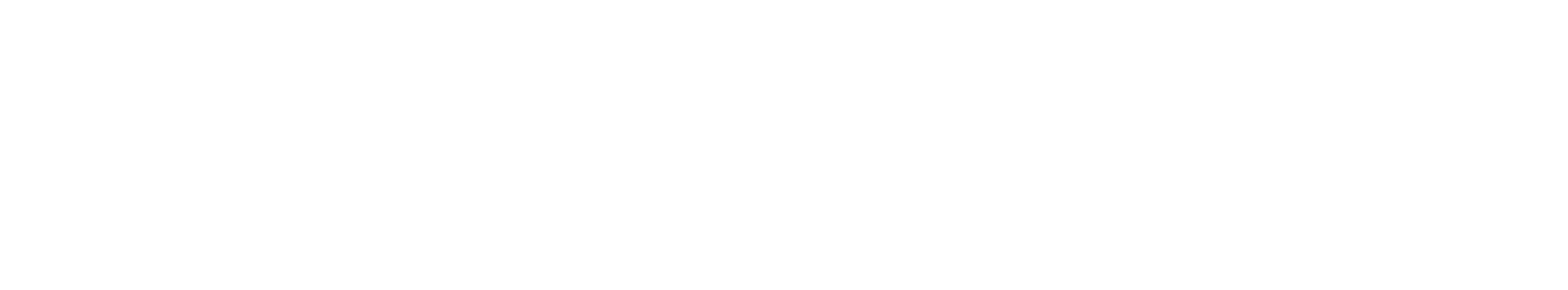La vita nella Roma di Fellini era «dolce». «La vita è bella», sostiene con ragione Roberto Benigni. «La bella vita» è il titolo del film che rivelò Paolo Virzì e Sabrina Ferilli. «Bella la vita» fu il primo libro di Lucio Dalla. Per Luciano Bianciardi la vita era semmai «agra». Fu «lunga» la vita di Marianna Ucria, raccontata da Dacia Maraini. Quasi mai si sente parlare di «vita buona».
Scola usa questa espressione senza moralismo, come una chiave che apre tutte le porte, che dà un’interpretazione della politica, del Sessantotto – sulle cui origini diede una lettura positiva tanto che Il manifesto lo definì «il cardinale beat» -, della scuola, della famiglia, del fine vita, dell’amore.
La sua idea è che il cristianesimo non penalizza le passioni, i desideri, financo gli istinti; anzi, esalta l’umanità, la differenza tra uomo e donna, l’attrazione per il bello.
Un concetto fondamentale della «vita buona» è il «bell’amore»: «Vivere la bellezza dell’amore significa strappare la sessualità al dualismo tra spirito e corpo; come se trattenessimo la sessualità nell’animalesco e poi a tratti avessimo spiritualissimi slanci di intenzione di bell’amore».
Scola rifiuta la distinzione tra Venere urania e Venere pandemia, pensa semmai come Pascal, quando diceva che «l’uomo è a metà strada tra l’animale e l’angelo, ma deve stare bene attento a non guardare solo all’uno o all’altro; ognuno di noi, inscindibilmente uno di anima e di corpo, ha da fare i conti con la dimensione sessuale del proprio io per tutta la vita, dalla nascita sino alla morte».
Come fecero i suoi genitori. Scola ama ricordare di aver visto «la verità e la bellezza dell’amore nello sguardo del mio papà verso la mia mamma dopo 55 anni di matrimonio». E anche nella gioia con cui tre bambini traducevano al patriarca in visita nella loro casa i movimenti degli occhi del padre, malato di Sla. «Mi sono sentito un verme», commenterà Scola.
Questa è per lui la vita buona: la forma più alta di libertà, in cui il voler essere e il dover essere coincidono – si vuol fare ciò che si deve fare -, animata dall’amore per il bello, il bene, il vero, l’eterno. Perché «non c’è amore senza promessa, non c’è promessa senza “per sempre”, e non c’è “per sempre” se non sino alla fine, sino e oltre la morte».
Il padre portò fino a Messina il prototipo del palo per l’illuminazione dello Stretto, impiegando 17 giorni. Senza autostrade e senza telefono, non si sapeva mai quando sarebbe tornato. Si ammazzò di lavoro per farci studiare». La madre, Regina, molto religiosa – «per lei credere era come respirare» -, mandava i figli a distribuire il giornale dei preti, il Resegone.
«Io stesso tra i 14 e i 18 anni, durante gli anni del mio liceo – ha scritto Scola -, ero preso dall’interesse per la politica in una maniera tale che l’appartenenza alla Chiesa è come caduta in secondo piano. Ero talmente conquistato dai problemi sociali, politici – avevo una simpatia per i partiti marxisti perché il mio papà era impegnato nel partito socialista di Nenni, quando era massimalista – che questi prendevano il sopravvento su tutto il resto.
Allora era come se Dio non ci fosse, come se la Chiesa non ci fosse, se Dio non contasse più. Mentre prima le domande più importanti della vita – Perché sono nato? Da dove vengo? Dove vado? Cosa sono al mondo a fare? Cosa vuol dire voler bene agli amici? Cosa vuol dire soffrire? Cosa vuol dire amare? – mi rodevano dentro, adesso le avevo messe a tacere. Era come se tutte queste cose non contassero più. Poi, grazie a Dio, alla fine del liceo ho trovato degli amici che invece vivevano in maniera più intensa tutto».
Tra quegli amici c’era un sacerdote che insegnava religione al liceo Berchet e aveva fondato Gioventù Studentesca: don Luigi Giussani. Formatosi nell’Azione Cattolica, Scola vive dal di dentro la fondazione e la crescita di Cl. Ma nessuno dei luoghi comuni evocati dagli avversari di Comunione e Liberazione lo riguarda. Non è settario, ha una visione aperta delle relazioni umane, è curioso delle persone e delle cose che non conosce. E il suo colore preferito non è il bianco né il nero, ma il grigio: da ragazzo è arrivato a contarne sul lago nove sfumature diverse; «è per questo che noi lacustri siamo un po’ crepuscolari, se non proprio romantici».
Scola ha dimostrato qualità di pastore e di comunicatore non scontate in un intellettuale. Ha saputo ascoltare mondi lontani dal suo, dall’arte contemporanea al cinema. All’ultimo meeting di Rimini ha parlato per due ore a diecimila giovani partendo da quattro film che aveva visto in vacanza: «Matrix» dei Wachowski, «Memento» di Nolan, «Fratello, dove sei?» dei fratelli Coen, «Il concerto» di Mihailenau.
Tra i cardinali italiani, è forse quello che dà e concede più facilmente il tu. Nelle discussioni pubbliche, chiede sempre il nome dell’interlocutore e con il suo nome gli si rivolge, magari per criticarlo, senza preoccuparsi di captarne la benevolenza. Ascoltarlo è un piacere intellettuale che richiede attenzione. E se qualcuno obietta che parla difficile, potrebbe sentirsi rispondere: «Chi dice così, di solito vuol sentire solo cose che già sa». Poi, ogni sera, prima di andare a dormire, il cardinale recita l’Ave Maria, come da bambino.
Questo è Angelo Scola. E ciò aiuta a capire perché Milano e i cattolici italiani guardano a lui con grande speranza.
29 giugno 2011 – Il corriere.it – Aldo Cazzullo – Il cardinale del dialogo che predica la vita buona – «Vengo con orgoglio da una famiglia poverissima» Dall’incontro con Giussani al libro con von Balthasar