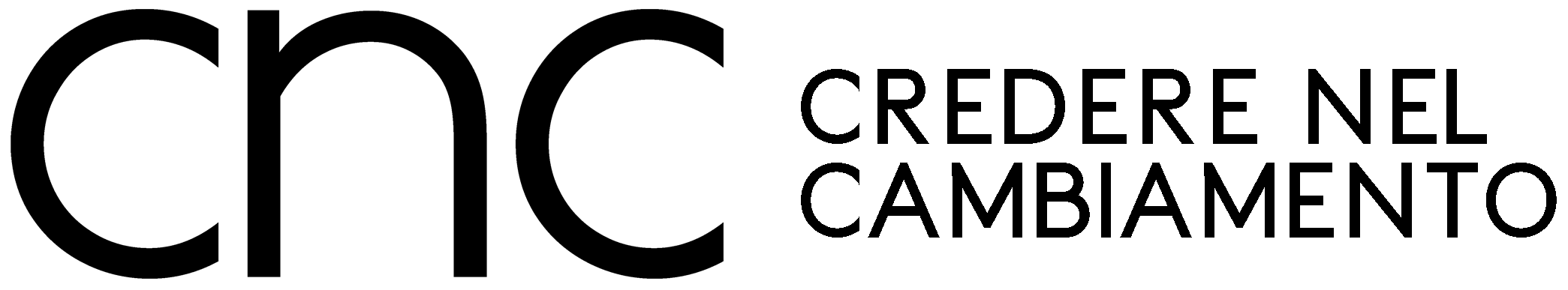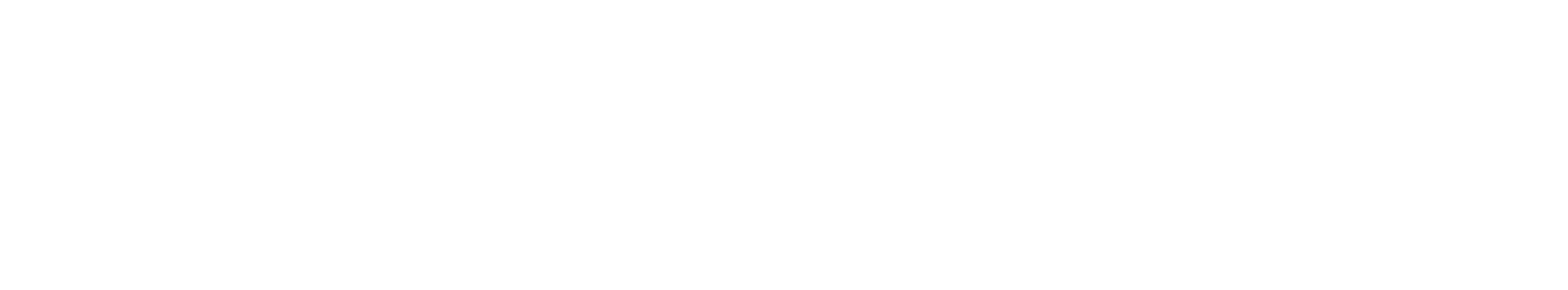«Eravamo certi di essere vittime di un’imboscata delle forze del regime. Dico a Pierre Piccinin, detenuto con me: “Qui ci sparano in testa, è l’ultimo minuto della mia vita”. Invece mi hanno portato in una stanza. Sento una voce da orco: “Tu sai dove sei. Io sono un colonnello della polizia di Assad”, mi dice un uomo.
E poi mi ha picchiato e sentivo l’odore della soddisfazione per avere la mia vita fra le sue mani. Mi hanno chiesto di urlare il nome di Assad. Hanno cercato di farci credere che erano uomini del regime. Ma sono bastati due giorni per capire che non era così e che erano i ribelli, miliziani che pregavano quattro o cinque volte al giorno, cosa che l’esercito non fa perché è contro gli islamisti. Poi i bombardamenti dell’aviazione su di noi hanno confermato il sospetto».
Quirico ha ribadito di aver sperato nella forza redentrice dei ribelli: «Ho creduto, e non lo rinnego, nella rivoluzione dei siriani per i primi due anni, nella possibilità che in quel Paese ci fosse una classe rivoluzionaria formata dai giovani, dagli intellettuali, da semplici cittadini che avevano deciso di trasformare il loro mondo.Ho creduto nella forza della giovinezza per la costruzione della Siria. Bene, la rivoluzione mi ha tradito e mi ha consegnato ad un fenomeno che io non avevo ancora individuato».
Durante i mesi di prigionia, mentre i rivoluzionari mostravano il loro volto il reporter si è «chiesto più volte se nell’affidarmi a questa rivoluzione io non abbia commesso errori tecnici», giungendo a una conclusione non scontata per un giornalista disposto a rischiare la vita: «Il mio errore è stata la vanità, vanità che qualche volta c’è nel mio mestiere. L’idea era: sono in grado di arrivare dovunque, farò qualsiasi cosa per andare là a raccontare una realtà che non ha mai visto nessuno. Ecco la vanità di cui sono stato vittima per 152 giorni della mia vita. Ma questo non è il vero problema.
Per la prima volta mi sono accorto che la mia vanità fa a sua volta delle vittime. Ci sono le mie figlie qui, a cui ho provocato un dolore immenso e mia moglie e tutta la gente che mi vuole bene. Uscirò migliore da questa storia se avrò imparato che non sono solo, che ogni mio atto riguarda anche altri. Se mi insegnerà l’umiltà la più difficile delle virtù. Se avrò imparato l’umiltà nel mio mestiere».
Alla domanda sul sentimento che si può provare per quelli che prima di partire si credeva di amare, Quirico ha risposto raccontando i tentativi di fuga e di uccidere i suoi aguzzini: «Ci eravamo impadroniti di due granate e abbiamo discusso a lungo se e come usarle. Quando questi ragazzi sono venuti per buttarci gli avanzi del loro cibo pensai che in quel momento non sapevano che la morte stava giocando fra la nostra e la loro stanza e non aveva ancora scelto in quale delle due sarebbe caduta.
Ero in grado di uccidere quattro esseri umani che erano miei carcerieri e torturatori, ma che in qualche misura erano diventati parte della mia vita. Ero in grado di farlo? Potevo lanciare la granata e ucciderli. Vi chiedete se non provavo qualche sorta di problema morale. Io non conoscevo il tempo in cui la granata sarebbe esplosa. Se il periodo fosse stato lungo avrebbero potuto scappare e uccidermi.
Sono stati giorni in cui calcolavamo la meccanica di una possibile evasione. Se avevo un problema morale? Erano i miei torturatori, anche se in qualche misura erano diventati parte della mia vita. Di uno sapevo che aveva famiglia, dei figli. Un altro era un ragazzo di campagna. Un terzo mangiava in continuazione, con la fame bulimica dei poveri e dei miseri. Il quarto, una sorta di “sciupafemmine” islamico, era sempre al telefono, con presunte fidanzate». Perciò il giornalista non riesce a parlare di odio, «ma erano comunque la mia dannazione e avrei avuto la forza di ucciderli. Il destino, però, me lo ha impedito quando abbiamo avuto la possibilità di provare a scappare». Ma durante i due tentativi di fuga Quirico e Piccinin vengono presi e riportati nella stanza.
Quindi provi odio? «Se vi dicessi che ho perdonato, mentirei. Perché per perdonare dopo questo occorre entrare nelle regioni della santità. Io sono un credente cattolico, come il mio compagno di prigionia Piccinin, e Dio era lì con noi: abbiamo pregato molto. Poi a un certo punto ho avuto l’impressione che Dio fosse evaporato. Che non ci fosse più. Ma non era vero anche in questa assenza Dio era lì, semplicemente mi ha insegnato che era sbagliato il modo con cui noi ci rivolgevamo a Lui chiedendogli la liberazione. Dio non fa patti, non vende la grazia.
Bisogna aspettare. È la differenza tra Abramo che non aspetta, come Dio gli ha chiesto, e vuole tutto subito, e Giobbe che invece aspetta e dopo aver perso ogni cosa otterrà ciò che ha chiesto moltiplicato per dieci».
Poi Quirico ha spiegato la sua «tendenza a leggere la storia in generale e la mia personale in termini molto semplici. Di colpa e redenzione, di peccato e grazia. Perché la mia fede è quella di quando ero bambino, forse una fede che non esiste più, fatta di parroci che andavano nelle case con la neve per portare la Comunione, una fede che spaccava le montagne, che attendeva e sapeva aspettare».
Quirico non solo non odia, ma finisce chiedendo perdono. Perché «se io scegliessi la strada dell’odio sbaglierei, resterei ostaggio. Tutto il male di questa storia rimarrebbe in me. Affinché non sia così devo avere la speranza di uscire migliore da questa storia. Per farlo la strada non è odiare, ma recuperare l’umiltà e chiedere perdono come ho fatto con mia figlia al telefono. Chiederò ancora perdono».
Siria. 16-09-2013 | Tempi.it
«Sono stato cinque mesi con il mio compagno a guardare il muro, ad aspettare che la porta si aprisse. E non si apriva mai». Sono le parole di Domenico Quirico, reporter della Stampa, prigioniero in Siria per 152 giorni e liberato l’8 settembre scorso.