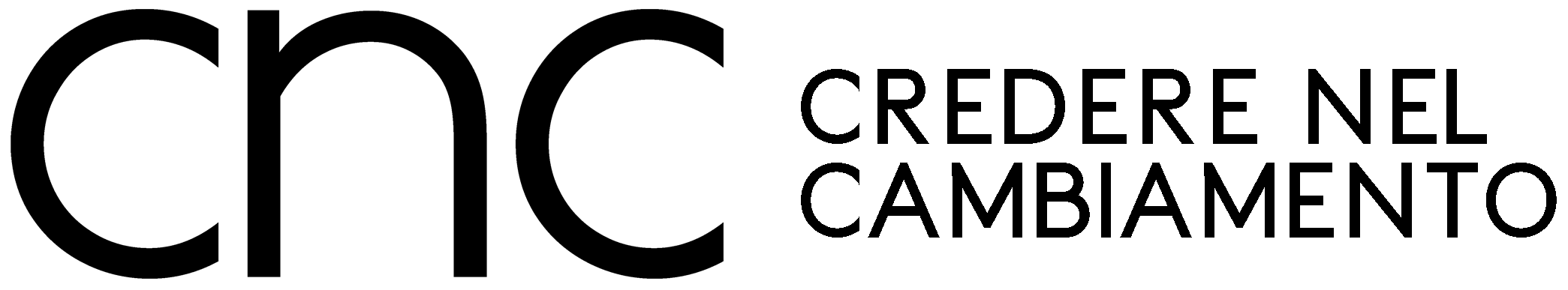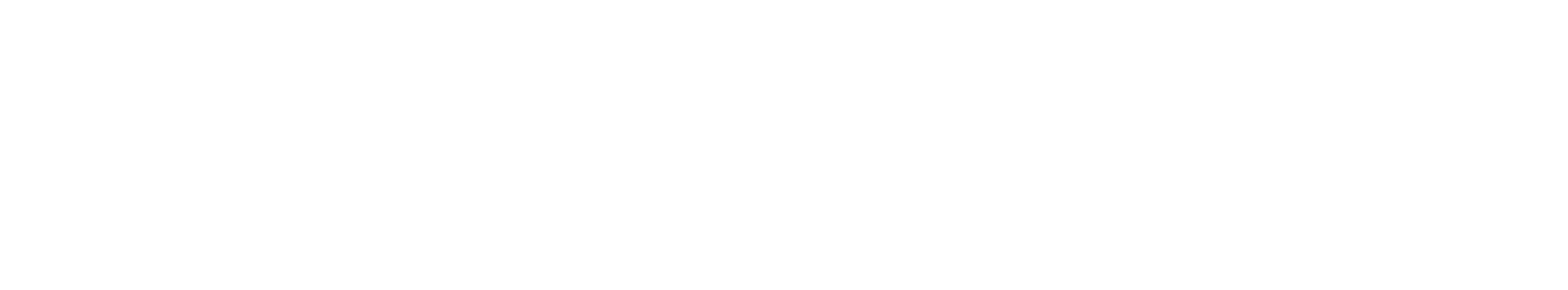La periferia del nostro stupore e della nostra incomprensione, della nostra rabbia e del nostro dolore, è tra le ultime case di Tripoli. Si chiama Shura Ashuk e per raggiungerla bastano dieci, quindici minuti di macchina.
Non ci mettono piede in molti. Ci vanno i mediatori per discutere il prezzo del carico d’umani. Ci arrivano, quando è il momento, gli emissari dei trafficanti di uomini incaricati di ritirare il carico da traghettare.
Ci va, due o tre volte alla settimana, suor Emma Moja. È l’unica tra i cuori affranti dell’Italia e dell’Europa a metter piede da queste parti. La sola a conoscere uno per uno gli angoli della sofferenza, i suoi volti, le sue malattie. Te lo racconta senza ipocrisie, senza mezzi termini. «Bisogna stare attenti. Lì dentro c’è di tutto, dalla scabbia alla tubercolosi, dalla polmonite a quel che neppure immaginiamo. Vivono e mangiano tutti assieme. Dormono stipati uno accanto all’altro, qualcuno di loro non esce mai da quelle case sporche e infestate. Come vuoi che non si diffondano le malattie? Sarebbe strano se non ce ne fossero».
Mentre te lo racconta suor Emma corre da una stanza all’altra della sacrestia di San Francesco, la grande chiesa di Tripoli sede dell’episcopato. Lì, tra le navate di quella chiesa – come spiega l’anziano vescovo Giovanni Martinelli –, s’affacciano qualche volta gli eritrei cristiani. «Vengono a recitare l’ultima preghiera prima dell’ultimo viaggio. È un fenomeno terribile che non capiamo e ci mette alla prova. Gli eritrei attraversano il deserto, arrivano qui con la pancia gonfia per poi cercare di salire sulla prima imbarcazione disponibile. Noi li vediamo, li ascoltiamo e ci sentiamo impotenti. Quando arrivano a Messa e chiediamo “dove andate?”, ci rispondono con quattro parole, dicono solo “il viaggio della morte”».
A cercar di rendere meno difficile l’attesa di quella traversata c’è soltanto Emma Moja. «Arrivano da ovunque – racconta –, hanno affrontato viaggi infiniti, si sono portati dietro i bambini, riescono a vedere un medico solo quando riusciamo a farli accogliere in uno degli ospedali di Tripoli. Ma ci vuole una procedura e io sono sola. Credetemi non è facile».
È sola da 14 anni, suor Emma. Da quando è arrivata qui in Libia e non è più partita. Da quando ha deciso di donare se stessa a quella chiesa sulla collina, all’opera silenziosa dell’anziano vescovo, alla sofferenza di quei relitti umani ancorati negli approdi di periferia prima dell’ultimo, disperato balzo oltre il Mediterraneo. Una volta varcato il Mediterraneo, se sopravviveranno, se approderanno, diventeranno il simbolo della carità pelosa dell’Europa e degli amici degli immigrati, delle organizzazioni umanitarie. Ma fin che son qui, sono reietti dimenticati, abbandonati, ignorati.
Suor Emma lo sa, ma non si scandalizza. Continua a fare quel che può senza accusare, senza recriminare. In silenzio. Prepara la sua borsa, monta in macchina, si lascia dietro il centro di Tripoli, s’infila nei vicoli di Shura Ashuk, sfila tra le facce pazienti degli africani allineati agli incroci in attesa di qualcuno disposto a comprare un’ora del loro lavoro.
«Li vedi? Molti di questi son qui a comprarsi il viaggio. Lavorano a casa dei libici, cambiano un tubo dell’acqua, ripitturano le stanze, abbattono muri, li ricostruiscono. Chi ha bisogno di muratori, idraulici, imbianchini, li trova a questi incroci. Se li carica in macchina, li porta a casa, gli fa fare quel che serve e li saluta. Molti di questi che vedi qui sui marciapiedi sono i fratelli, i mariti, i padri o i figli di quelli che stiamo andando a trovare. Escono dalle stesse case-deposito dove attendono di partire. Devono lavorare per pagarsi l’affitto e mettere da parte i soldi per riuscire a partire. Intorno a loro gira l’ingranaggio di una grande economia. Senza di loro i libici non avrebbero nessuno a cui affidare alcuni lavori. Ma senza di loro molti libici non farebbero fortuna».
L’ingranaggio di Shura Ashuk è l’ultimo. Tra queste palazzine marciscenti, tra questa derelitta distesa di asfalto, polvere ed edifici abbandonati gira l’ultima ruota della grande catena della disperazione messa in moto a migliaia di chilometri di distanza tra le foreste pluviali dell’Africa centrale, gli altipiani eritrei, le sabbie somale.
Qui l’umanità in fuga dalle spietate milizie al qaediste di Mogadiscio o Kismayo, dalla folle dittatura di Asmara, dalle disgrazie e dagli odi dell’immensa Africa si raccoglie, si assembra, attende. Qui il tritacarne della sofferenza ha già spremuto tutto quel che si poteva. L’ultimo ingranaggio della vessazione s’occupa di scaricarli nel Mediterraneo dopo aver succhiato loro l’ultimo pacchetto di dollari cuciti nella piega del vestito o guadagnati all’angolo delle strade.
Ora siamo arrivati. Suor Emma parcheggia davanti a una delle palazzine. Bussa a una porta sgangherata di legno tenuta chiusa dal fil di ferro. Da dietro arrivano urla di bimbi, grida di mamme, vociare confuso di uomini e anziani. Un occhio s’affaccia alla fessura tra gli stipiti, sorride a Emma, ci squadra sospettosi. «Amici miei», dice lei.
Siamo dentro. Il deposito di umani è un cortile assolato, disegnato nel rettangolo di questa palazzina. Su ogni lato quattro o cinque stanzoni, e dentro ognuno di quegli antri trenta, quaranta, cinquanta umani in attesa. Carichi parcheggiati in attesa di trovare un traghettatore e poterlo pagare. Carichi diversi per tipologia e per prezzo. Ci sono le famiglie con donne, uomini e bambini. In due o tre s’affittano uno stanzone, ci vivono dentro in attesa che i mariti lavorino e trovino il contante necessario. Poi ci sono le stanze delle donne e infine quelle degli uomini.
Nel cortile assolato vagano uomini vestiti di stracci, ruzzolano bimbi di tutte le età, sciacquano il bucato decine di donne avvolte in scialli a fiori. Tutt’attorno il lezzo di urina e sudore si mescola all’aroma vaporoso di cibo ribollito. Trasuda dalle tende, tirate alla meglio per chiudere otto stanzoni trasformati in gironi dell’attesa. «Una di queste camerate può costare 100 dollari a testa al mese. Una famiglia può ritrovarsi a pagare anche 300 dollari, prova a pensarci… anche questo è un bell’affare», racconta suor Emma. Lei non dice di più, ma se chiedi in giro scopri che tanti uomini d’affari libici hanno investito su queste casette in rovina. Le hanno acquistate a poco prezzo e ora incassano lauti affitti tenendoci parcheggiati i prigionieri dell’ultimo viaggio.
Suor Emma c’ha fatto il callo. Lei ha altre preoccupazioni. La scabbia è il suo grande nemico. «Ce l’hanno praticamente tutti, se la passano uno con l’altro. Ogni settimana distribuisco un po’ di medicine, ma anche noi abbiamo difficoltà a procurarcele. Non bastano per tutti». Non dice di più. Anche stavolta alza soltanto gli occhi al cielo. Per capire a cosa pensa non serve l’illuminazione divina, basta guardarsi attorno. Qui non mette piede una sola organizzazione umanitaria. Qui non s’affaccia l’ombra di un delegato europeo. Dove Emma arriva da sola, trascinando il suo borsone di medicine, non si vede l’ombra di un delegato di quell’Alto commissariato per i profughi delle Nazioni Unite che qui in Libia ha speso nel 2013 oltre 13 milioni di dollari.
Dove sono andati quei soldi? Di certo non sono arrivati in questo limbo desolato. Di certo non hanno contribuito ad arrestarne il degrado, le malattie, la sofferenza. «Se c’è un malato grave, se c’è un caso di polmonite come capita spesso – spiega Emma – ci rivolgiamo all’ospedale libico, sono loro ad accettare il ricovero e farsi carico delle cure. Noi per ora non abbiamo altri referenti».
Dal girone delle famiglie s’affaccia Ibrahim. È fuggito dall’Eritrea nel 2007, ha attraversato Sudan e Sahara. Il passar di anni e deserti è disegnato nelle rughe del suo volto. Ibrahim ti fa segno d’entrare. Sulla stuoia sudicia è raggomitolata Lettenzi, sua sorella. Ha 38 anni, un’accettata di dolore le taglia la schiena, la piega al pavimento. «L’Italia – sussurra Ibrahim – è la sua ultima speranza, qui non la cura nessuno, se non ci mettiamo su una barca la perderò».
Come tutti i duecento e passa inquilini di questa palazzina-parcheggio, attendono solo la traversata per l’Italia e l’Europa. Con loro ci sono Danait, Mikias e Zara. Hanno dieci, otto e tre anni, sono i figli messi al mondo da Lettenzi e dal marito negli anni della transumanza. Il marito e i due rampolli più grandi, Nardos di 17 e Miral di 19, sono a lavorare, a raggranellare il malloppo per il viaggio. «Dobbiamo tirar su 1.600 dollari a testa per me, Lattanzi e suo marito. I figli non pagano. Vogliamo partire adesso, tra giugno e luglio, quando il mare e più calmo».
Ma neppure riuscire a salire su una carretta dei mari è una certezza. «Di notte in queste case – racconta Emma – succede di tutto. Arriva gente armata che si porta via le persone. Quando va bene sono gruppi di poliziotti venuti per intascarsi una tangente. Quando va peggio sono bande di veri criminali decisi a prendersi i soldi di questi disgraziati». Sanno che ognuno qui ha nascosto da qualche parte i soldi del viaggio e vengono a prenderseli.
A volte va anche peggio. «Ho passato quattro mesi nella galera di una milizia e mi sono pentito di esser fuggito dalla Somalia. Neanche in mezzo alla guerra, neppure tra gli shebab ho visto cose del genere – racconta Omar, arrivato fin qui da Kismayo –. Quando uno di loro veniva ferito negli scontri con le altre milizie ci portavano all’ospedale e ci costringevano a donare il sangue. Una volta mi hanno succhiato mille centimetri cubici. Poi mi hanno riportato in cella e sono finito in coma. Di notte bevevano, si ubriacavano e per divertirsi sparavano con i kalashnikov dentro le nostre celle. Non so come, sono sopravvissuto.
Credetemi, dopo quel che ho passato preferisco morire in mare piuttosto che restare qui».
Tratto da : Periferie esistenziali. Tripoli, tra i profughi diretti in Italia | Tempi.it – Giugno 30, 2014 – di Gian Micalessin