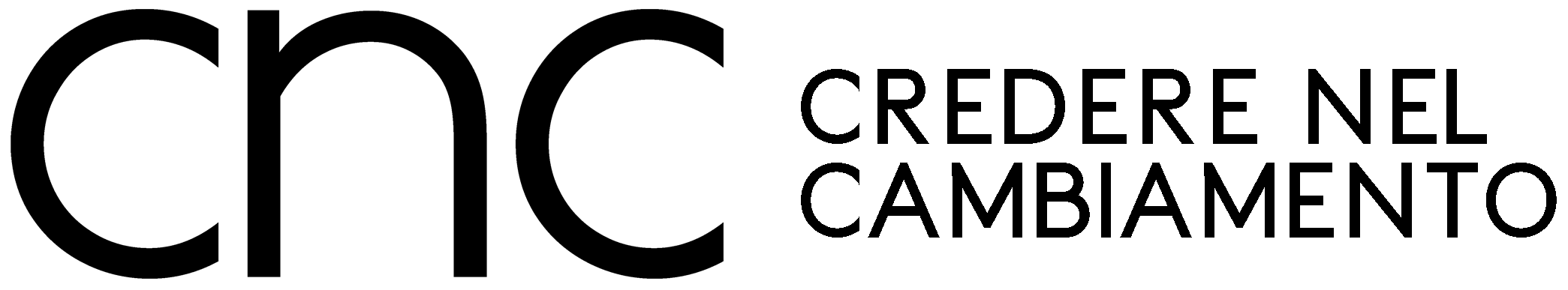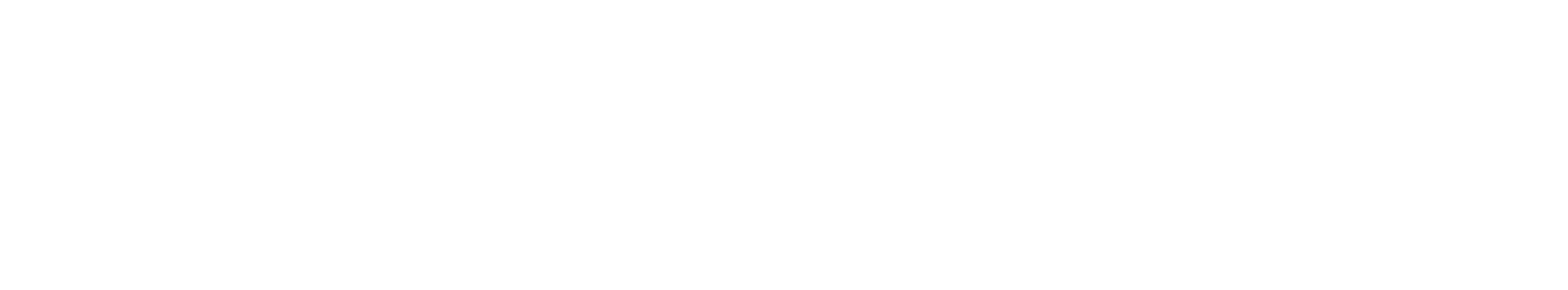La generosità e l’eroismo tipico di questi giovani, li portano spesso a trascurare o a non dare valore agli studi o alla professione precedente e futura, tanto forte è il desiderio di consacrarsi interamente alla nuova realtà.
E così la vocazione invece di servire e potenziare i talenti umani e lavorativi, troppo spesso si trasforma nel tempo in una specie di professione in sé, che assorbe tutto il resto.
L’ora et labora non a caso era nel DNA delle prime esperienze monastiche. Anche i primi francescani vivevano in genere del loro lavoro. Molte riforme della vita monastica sono state soprattutto riforme del lavoro, perché l’ora tendeva con il tempo a divorare il labora.
L’ora aiuta il labora, ma anche il lavoro aiuta la vita spirituale, perché è in se stesso attività spirituale e carismatica. E chi è riuscito a salvare e a sviluppare un lavoro vivendo dentro comunità carismatiche lo sa molto bene. Lo sa se ha salvato un lavoro vero, perché è molto difficile lavorare veramente quando una vocazione si sviluppa dentro comunità ideali. Si fanno molti “lavoretti” per mantenersi o intrattenersi occupati, ma raramente si lavora veramente, coi tempi, responsabilità, disciplina, fatiche del lavoro.
Alla radice di questo errore, grave e comune nella formazione delle giovani vocazioni, c’è una visione aristocratica e gnostica che considera le attività “spirituali” superiori di quelle lavorative, come se una liturgia o una Messa fossero sempre e per natura attività più morali e degne di un’ora trascorsa semplicemente lavorando – una tesi a volte sostenuta da esegesi creative del brano evangelico di “Marta e Maria”.
E così non stupisce che una delle crisi più comuni, sebbene molto sottovalutate, della vita religiosa adulta dipenda dal mancato sviluppo della dimensione lavorativa da giovani. Perché si vede il lavoro come un male necessario, che toglie tempo prezioso all’unico “lavoro” buono della missione.
E anche quando alla missione è inerente e intrinseco un mestiere (per esempio, insegnare o curare), è ancora più importante che la dimensione lavorativa sia distinta, accudita e curata, e mai usata strumentalmente ai fini della missione, e quindi snaturata. Solo un lavoro amato e rispettato può essere un giorno lasciato, quando la stessa vita chiamerà altrove. Ci si “attacca” sempre al lavoro fatto male, quando diventa “servo” o “padrone”.
Se il lavoro è invece visto e riconosciuto per quello che veramente è, lo si lascia con la stessa dignità dolorosa con cui si lascia un figlio libero di seguire la strada che non avevamo pensato per lui.
Lavorare veramente è allora vera laicità, cioè espressione dell’essere semplicemente uomini e donne. Il lavoro è la possibilità di sentire e ascoltare il battito del cuore della propria città, del proprio tempo, della propria gente vera.
Non sempre è possibile lavorare veramente nella vita. Ma occorre vivere il non-lavoro come una indigenza, non come un privilegio o una elezione. Soffrire per non essere diventati lavoratori, e qualche volta ritrovarsi sanati dentro proprio grazie a questa sofferenza.
Un responsabile di comunità che ha lavorato veramente, o che ha sofferto per non averlo potuto fare, farà sì che i giovani che arrivano nelle comunità seguendo una vocazione possano ricevere il dono di far bene un lavoro vero. Magari per qualche anno, per poco tempo, ma un lavoro vero, non “lavoretti”.
Tratto da : Il doppio miracolo del pane – Luigino Bruni – 21/05/2016