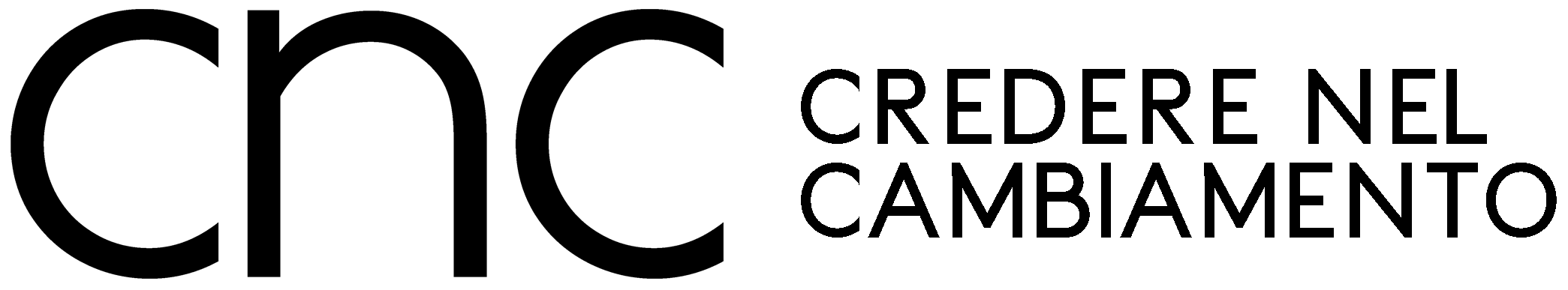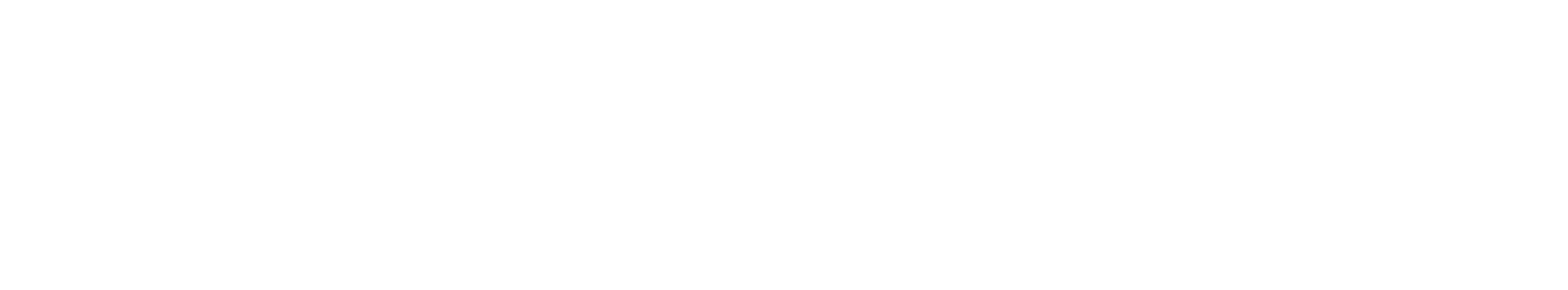Filippo ha ventiquattro anni ed è laureato in Design automobilistico. Ironico ed intelligente, da qualche anno lavora a Torino alla Pininfarina in attesa di spostarsi a Maranello, negli stabilimenti Ferrari. Ci parla della sua breve esperienza alla Spei, offrendo qualche opinione personale sulla funzionalità ed il progetto generale della ditta.
Come sei arrivato alla Spei?
Nell’autunno 2011, mentre stavo preparando la tesi di laurea, stavo facendo un paio di lavoretti – call center e consegna delle pizze – mi guardavo in giro. Appena laureato fui contattato da un ragazzo, che adesso è il mio capo a Torino, alla Pininfarina – mi ha preso con l’intenzione di formarmi e poi mandarmi a lavorare in Ferrari, a Maranello. Stefano era il mio vicino di casa. In quel periodo sentì dai miei genitori quello che stavo facendo: il programma che usavano alla Spei, Catia, era quello che usavo anch’io, così volle farmi vedere come lavoravano in ufficio. Sapeva che in quel periodo stavo cercando.
Avete fatto il colloquio?
Una specie di colloquio, non era ben chiaro se volesse assumermi o meno. Voleva più che altro farmi vedere in cosa consisteva la Spei.
Come mai, secondo te?
Non lo so. Ho pensato che volesse capire se assumermi o no, se gli sarei potuto servire professionalmente. Abbiamo parlato del lavoro che faceva, del suo studio, di come era impostato, e ha cercato un pochino di schiarirmi le idee.
E te le ha schiarite?
Diciamo che lui tratta l’ufficio sia dal punto di vista professionale che da quello (molto) religioso. Era la mia prima esperienza lavorativa, e non ho avuto le idee così chiare. Sono stato in Spei un mese e mezzo.
Dell’aspetto religioso cosa ti ha detto?
Mi ha detto che ci teneva molto, che durante la settimana faceva varie riunioni e dibattiti.
Hai lavorato in quel periodo?
Lavoravo su Catia. Non so se ciò che facevo fosse solo un esercizio o se il mio lavoro servisse veramente alla ditta, comunque sì, ero davanti al computer quattro ore al giorno, o al mattino o al pomeriggio, incastrando la Spei con gli altri due lavori – consegnerei pizze tutta la vita se pagassero di più [sorride, ndr].
Ti ha pagato alla fine?
Lui? No.
Non volevi farti pagare?
In realtà sì. Ma essendo che era il mio vicino di casa, che lavoravo solo quattro ore al giorno, che era tutto molto spirituale, che in ufficio si vedeva che c’era molta gente che aveva più bisogno di me, non gli ho chiesto niente.
I tuoi genitori cosa dicevano?
Da un certo punto di vista erano contenti, perché stavo provando qualcosa di nuovo; da un altro – come me – erano un po’ contraddetti perché non si parlava di futuro o di tipologie di contratto… In quel periodo lì – e ancora adesso – non capisco se veramente la Spei riesca a vendere qualcosa ed ha clienti che la supportano oppure faccia un po’ fatica.
No no, ce la fa. Adesso ha tre o quattro clienti che vogliono disegni, ed uno manuali. Le entrate non mancano. Siamo in una dozzina, ma solo cinque disegnatori…
Un po’ di sproporzione… [ride, ndr]
Tutti part time, tranne i disegnatori che lavorano esternamente otto ore al giorno… In quel mese e mezzo andavi alle riunioni del giovedì?
Sono andato a un paio di riunioni. C’era la preghiera e poi si parlava di un argomento di carattere religioso, una sorta di dibattito-confronto.
Si andava anche su cose personali?
Stefano introduceva un argomento, chi voleva poteva dire la sua. Era tutto libero e volontario.
Tu sei credente? Facevi la preghiera?
Sì sì. Ma non era vincolante, chi voleva veniva, chi non voleva no: la presenza aveva un carattere volontario.
Sei anche praticante?
Sono praticante a momenti [sorride], ero così anche al tempo della Spei.
Della serie “credo in Dio ma non nella Chiesa”?
Eravamo in una parrocchia appena nata dall’unione di due vecchie parrocchie (“Maria Immacolata” e “San Giuseppe Artigiano”). C’eravamo stabiliti in una nuova chiesa, “Gesù Redentore” – sembra una fabbrica, non si capisce cosa sia. I due sacerdoti erano [don Marco] e [don Graziano], che già prima facevamo unità pastorale: il secondo era molto ben voluto, il primo non era molto capace di gestire la parrocchia – poverino, forse sarebbe più adatto come eremita che come parroco. Dopo poco tempo rimase solo don Marco, non mi piaceva più frequentare: a Torino, invece, ogni tanto andavo a Messa – ma era molto scomodo, dovevo fare “migliaia” di chilometri.
Cosa non ti andava bene della nuova parrocchia?
A “Maria Immacolata” mi trovavo molto bene, avevamo un bel gruppo. Dopo l’unione non trovavo più motivi per andare avanti.
Con Stefano avevi parlato di queste cose? Anche lui frequentava la parrocchia di “Gesù Redentore”.
Può darsi, può darsi…
Il mese e mezzo alla Spei ti ha dato una svolta spirituale?
Allora ero più preso dalla tesi e dal pensiero di cosa fare della mia vita, non sono stato molto attento a quello che accadeva in ufficio. Ero più preso dalle mie cose, poco interessato alla preghiera.
Non riuscivi a mettere “le tue cose” dentro la preghiera?
Sì, ci riuscivo, e più o meno ogni tanto ci riesco ancora – ho parlato con don Graziano, qualche volta. Però non sono riuscito ad assorbire molto dalla Spei, ero un po’ confuso e cercavo di schiarirmi le idee.
Ci sei riuscito? La Spei ti ha aiutato?
Quel mese e mezzo mi ha aiutato a capire che quello non era il mio lavoro. Stefano ha cercato di farmi fare un po’ di design, ma con Catia era impossibile, è un programma troppo tecnico e inadatto per fare quello che volevo fare – e comunque i lavori che mi venivano assegnati non seguivano la mia strada.
Come sei andato via dalla Spei?
Un giorno ho salutato Stefano dicendogli che non avevo tanto tempo perché dovevo finire la tesi, che avevo tanti impegni, e che comunque quel tipo di lavoro non era per me.
E lui cosa disse?
In questo momento non ricordo tanto bene… Mi sa che mi augurò tante belle cose e mi strinse la mano [sorride].
Alla Spei ci sono due tipologie di gente: chi sta lì e non potrebbe stare da nessun’altra parte, e chi è lì solo di passaggio – anche Stefano, con alcuni, presenta il periodo Spei come “tappa”: sembra proprio il tuo caso. Una volta schiarite le tue idee, Stefano avrebbe potuto dirti: <<Oh, le tue idee sono schiarite?>>
Può darsi. E può darsi che fosse effettivamente per quello che non mi parlava di contratti e non mi pagava.
Eri amico con Stefano? Che rapporto c’era tra voi?
Beh, sicuro non un rapporto capo-dipendente, più un rapporto “vicino di casa-figlio dei vicini di casa”. “Amico” è un po’ particolare come definizione perché comunque non abbiamo mai parlato così tanto da dire “ci conosciamo a fondo e siamo amici”; inoltre, al tempo, sentivo molto di più la differenza di età.
Con altri dipendenti avevi legato?
No, non molto. Lavoravo spesso al pomeriggio in ufficio, non c’era mai molta gente.
Sei mai andato “fuori” dalla Spei con gli altri? Magari qualche esperienza di carità…
Non con gli altri, le facevo per conto mio. Andavo ogni tanto alla Casa della Carità di Gesù Redentore.
Stefano parla sempre della Provvidenza e dei suoi segni, interpreta tutto quello che succede come un segno.
Mi ricordo che citava sempre i segni della Provvidenza, ma non ricordo bene degli esempi. Sicuramente quando me ne andai interpretò come segno provvidenziale il fatto che ognuno di noi doveva prendere la propria strada. Penso che me lo disse esplicitamente.
Della serie “Dio ti ha mandato qui e Dio ti fa partire”?
Una cosa del genere.
Credi che sia stato proprio così?
Essendo credente dovrei dirti di sì, essendo poco frequentante ti dico “può darsi”: la certezza ce l’ha Stefano…
E Dio…
Soprattutto Dio [sorride].
Ti dava fastidio qualcosa dell’impostazione spirituale della Spei?
Ogni tanto qualcosa mi sembrava un po’ eccessivo, considerando che era un ufficio lavorativo. Non mi sarei mai aspettato di trovare alla Spei una cosa del genere: parlo da un punto di vista estetico – l’arredamento era pieno di oggetti religiosi, non si poteva non vederli. Stefano lasciava tutti liberi di partecipare o no alle riunioni di preghiera, ma i messaggi [d’invito] c’erano: era un po’ un’ambiguità. A me non dava fastidio, e credo a nessuno: la gente che va lì, secondo me, non vuole fare carriera o avere un lavoro stabile, ma ha bisogno di un aiuto – difficilmente potrebbe lamentarsi per l’arredamento.
Alcuni si lamentano… Magari proprio chi ha ricevuto di più. Ma è missione anche quella.
Sì, lo so [sorride]. C’è molta differenza tra l’Europa e il Sudamerica: sono stato un paio di volte Brasile e in Paraguay, presso alcune missioni: lì chi ha bisogno non si lamenta, perché sono veramente poveri, e quindi sono più aperti, più disponibili. Qui se hai un pezzo di pane e mezzo lo mangi tutto all’istante, là magari doni il mezzo pezzo a chi è pure nel bisogno.
Così com’è, la Spei può funzionare?
Dipende da dove vuole arrivare. Se lo scopo della ditta è quello di aiutare la gente, di fargli trovare la propria strada, secondo me può riuscire benissimo. Se vuole diventare un ufficio di successo ed aumentare i dipendenti esponenzialmente, lavorare 24 ore su 24 e fatturare chissà cosa, no.
E secondo te vuole fatturare chissà cosa?
Secondo me no [sorride].
L’obiettivo è quello di aiutare la gente, il lavoro serve per vivere. Non c’è “mai di più”, ma neanche “mai di meno”.
Nel periodo in cui lavoravo io, la Spei era un po’ in difficoltà: era il boom della crisi economica, Stefano l’ha sentita molto. In quel periodo mi sa che fosse alla ricerca di altre forme di reddito.
Dici di aver fatto parecchie esperienze di carità in Sudamerica, oltre a quella nella Casa della Carità cittadina…
Anche nel rapportarsi con le altre persone c’è un aspetto spirituale. Cerco di farlo senza pensare solo a me stesso, ma anche agli altri. Dove lavoro, adesso, la maggior parte delle persone ti aiuta finché l’aiutarti non mette in difficoltà sé stessa: questo vorrei cercare di evitarlo, come stile e come persona.
Di che aiuto parli?
Di un aiuto da tutti i punti di vista.
24/09/2014