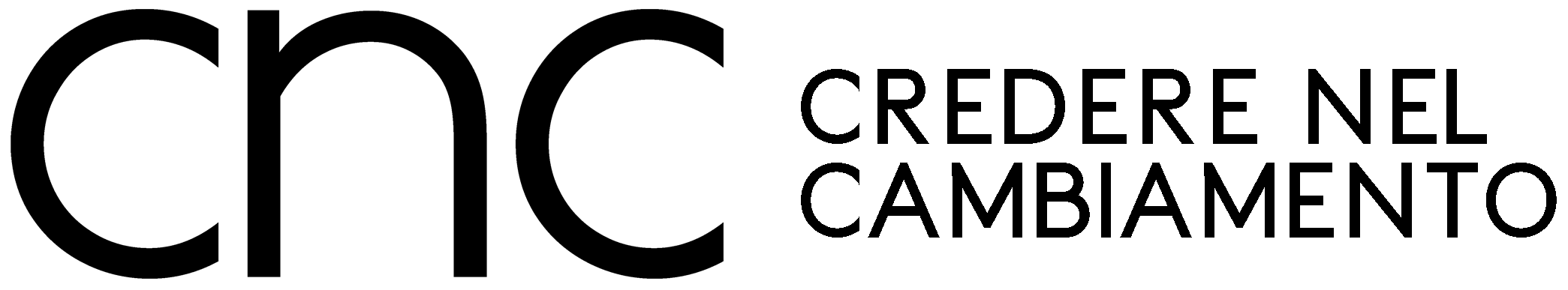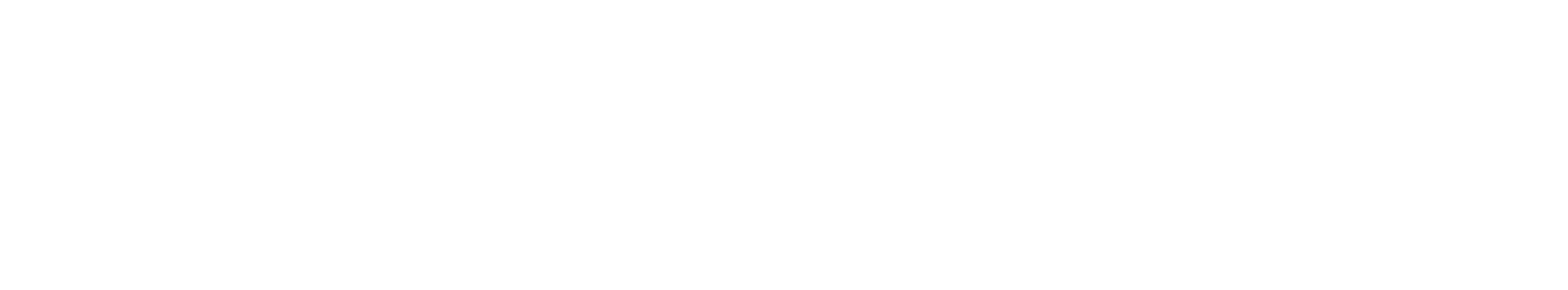Quando questa mattina sono arrivato a Modena, ho trovato Andrea sulla porta dell’ufficio. Lo sapevo in una ditta di Sassuolo a svolgere il primo lavoro esterno come uomo Spei. Qualcosa non ha funzionato, il cliente ha pensato di rivolgersi a un altro ufficio tecnico perché Andrea non ha evidentemente l’esperienza sufficiente. È bravo, ma il cliente vorrebbe un ragazzo già completamente formato, perché “non c’è tempo da perdere”. Andrea si è diplomato come geometra due anni fa, e da quel giorno solo la Spei ha voluto credere in lui: colloquio e assunzione nel giro di due giorni, senza ovviamente la certezza delle sue capacità né di un lavoro per lui.
Quando questa mattina ho visto Andrea sulla porta dell’ufficio, ho tentennato; ho pensato ancora una volta che i miracoli non possono accadere, e che dovremmo stare al passo con gli standard richiesti dal mondo. E sono standard freddi, spesso disumani: standard per cui un commerciale dovrebbe essere nato tale, vendere “blocchi di competenze” invece che trovare lavoro per colleghi come lui, limitarsi a strappare un contratto quando serve, metterlo sulla scrivania del capo in completa autonomia e chiedere la percentuale dovuta.
Per più di un attimo ho pensato che la ditta che ha rifiutato Andrea avesse tutte le ragioni del mondo, che la Spei non possa permettersi di proporre un ragazzo sì volenteroso, ma alla prima esperienza. Fuori dalla Spei, avrei tutte le ragioni del mondo per vederla così.
Però, chi mai farà fare ad Andrea la prima esperienza? Chi crederà in lui, oltre Stefano? La Spei non è un’isola deserta, non è un paradiso autarchico, né un monastero: ha bisogno di persone e ditte che la sostengano, con fiducia e lavoro. E ha bisogno innanzitutto della fiducia di chi ci lavora. La stessa fiducia che gratuitamente ha ricevuto. La fede nella possibilità per tutti i colleghi.
Ancora più drammatico che perdere un cliente sarebbe arrendersi allo scetticismo, allo sconforto, e gettare le armi a terra. L’errore da evitare oggi è sostenere che “effettivamente Andrea non era in grado di lavorare là dentro, perché non ha esperienza”, e che quindi “non ci si può fare niente”. Credere questo equivarrebbe a credere che la Spei debba chiudere i battenti: se si ragiona col mondo, la strada è effettivamente quella. Alla base di questo errore ce n’è un altro, una sorta di peccato originale da lavare al più presto per rimanere vivi: sforzarsi di far finta che la Spei sia da trattare come qualunque altro ufficio tecnico.
Non è così. Nessun ufficio tecnico del mondo continuerebbe a mantenere quattro commerciali part time, assunti prima ancora dell’effettivo bisogno della ditta: in un qualunque ufficio tecnico delle nostre dimensioni, l’unico commerciale sarebbe il capo, si farebbe chiamare manager, e ogni fine mese si darebbe uno stipendio. Nessun ufficio tecnico del mondo continuerebbe a mantenere per anni disegnatori che non riescono ad essere piazzati: qualunque ufficio tecnico terrebbe nel proprio organico solamente i disegnatori effettivamente impegnati presso ditte esterne; al momento, alla Spei questi sono solo tre; a quelli inattivi, comunque, non viene detto: “Ciao, se ho bisogno ti richiamo”. Nessun ufficio tecnico del mondo spenderebbe risorse per pagare uno che scrive sul blog della ditta, perché nessun ufficio tecnico del mondo, a parte la Spei, ha un blog della ditta in cui raccontare una storia come la nostra, le storie delle nostre persone, perché noi siamo diversi. Non siamo “qualunque ufficio tecnico”. Per nostra fortuna, o saremmo a spasso: va riconosciuto.
Stare dentro la Spei significa accettare la sua radicale diversità come una risorsa e non come un handicap. Perché la Spei è fatta così. E se così non fosse due terzi dei dipendenti, me compreso, sarebbe senza lavoro in coda al sindacato, o all’ufficio collocamento, a maledire il mondo: perché il mondo ragiona così, e se ne frega se le sue logiche sono cattive.
Come il disegnatore della Spei deve tenere presente che con il proprio lavoro mantiene sia la propria famiglia sia i colleghi del marketing sia i disegnatori non attivi, così il commerciale deve tenere presente che col proprio lavoro deve trovare un posto per Aziz, per Dino e per Andrea che al momento sono fermi. Non “un lavoro per chiunque”: per Aziz, per Dino e per Andrea che stanno aspettando e sono in grado di lavorare ognuno con le proprie capacità e le proprie risorse. Così, quando scrivo un articolo, devo tener presente che, oltre a me, anche Aziz, Dino, due Andrea, Susanna, Enzo, Khalifa e Luana sono dipendenti Spei e non lavorano esclusivamente per loro stessi. Non possiamo far finta di essere un altro ufficio tecnico, perché siamo la Spei: e crediamo che Andrea avrebbe potuto tranquillamente servire nella ditta che stamattina lo ha rifiutato, perché Andrea è bravo e sarebbe bastato lasciarlo alla prova. Noi per primi dobbiamo crederlo e convincere chi non ci crede. Ma se la Spei non crede nella Spei, allora è finita, ed è giusto chiudere e mettersi in fila al Collocamento.
Certo non è facile credere che possiamo farcela, ma non è nemmeno facile per Stefano pagare quattro commerciali, tre disegnatori inattivi, un amministratore contabile e un blogger. Non è facile credere ma siamo chiamati a farlo, perché stare alla Spei è una vocazione, forse non perpetua, ma è una vocazione. Il giorno che, liberissimo di farlo, deciderò di non credere più che Andrea, o Aziz, o Dino, o Gianluca, siano in grado di essere piazzati presso un cliente, dovrò andarmene dalla Spei, e propormi a un altro ufficio tecnico: sarei altrimenti un ladro di stipendio, un truffatore. Fuori dalla Spei è pieno di ditte che non ragionano come la Spei: il mio posto sarebbe lì.
Essere dipendente Spei significa credere nella missione Spei, che è una missione di servizio, e non solo tot soldi per tot ore di lavoro.
giorgio casali